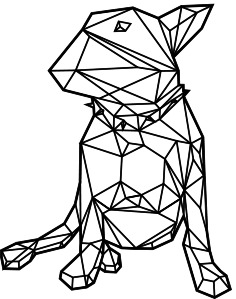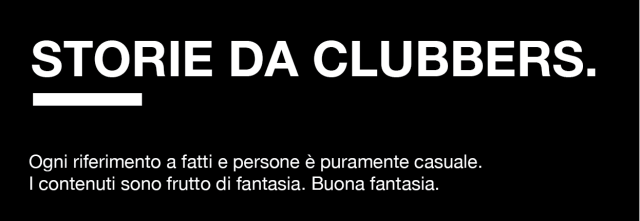

© IndustrialStrange. Ogni riproduzione intera o parziale è vietata.
Ogni riferimento a fatti realmentente accaduti o persone e luoghi realmente esistiti è frutto di fantasia. Si consiglia la lettura ad un pubblico adulto.
G.R.A. USCITA RAVE
Roma, estate ‘92. Un’afa che ti si appiccica addosso come una seconda pelle. L’aria sa di asfalto, smog e sudore, ma a noi non frega un cazzo. Siamo in tanti, troppi, caricati a molla, occhi sbarrati e mascelle che macinano aria. Un campo da calcio spelacchiato, polvere e sassi, consolle in mezzo e casse impilate come idoli pagani. La musica martella, pompa nel cervello, e tutto fila liscio… per un’ora. Poi il cielo si squarcia.
Pioggia. A secchiate.
L’acquazzone ci si rovescia addosso come una maledizione voodoo. Le luci sfarfallano, l’impianto tossisce, e dopo venti minuti la sentenza è chiara: rave finito, 3000 romani con 50mila lire in meno e una carica chimica che chiede giustizia. Qualcuno urla:
“MEGA-PARCHEGGIO DELLA PISANA!”
Boom. La voce viaggia veloce come il basso in cassa dritta. Fari accesi, tergicristalli impazziti, auto in colonna sul Raccordo. Noi in Clio, stretti come sardine, guidati da Sandro il Black, carnagione color carbone e un cervello in overdose perenne di incoscienza.
“State sereni,” dice. “Vi ci porto io.”
Non lo vedremo mai, il parcheggione. Dieci minuti e siamo già persi, dispersi, sputati fuori sulla Roma-Civitavecchia. Dietro di noi solo un’altra macchina: due sorelle techno e un tipo dall’aria smarrita. Il diluvio si incazza sempre di più, e BAM, l’auto delle ragazze muore stecchita. Tocca scendere a spingere, fradici, infangati, le scarpe che fanno CIAK CIAK sotto la pioggia battente.
E poi: il lampo.
Un’esplosione di luce a cento metri, un flash che ci fotte la retina, il cuore che salta un battito.
Silenzio.
Poi la pioggia riprende, la macchina riparte, e noi con le mutande bagnate e i battiti accelerati cambiamo rotta: si va al Mithos di Ostia, l’unico after-hour della capitale. Strade mezze allagate, un testacoda sulla rampa d’accesso, la Clio che danza da sola come un’ubriaca e noi fermi, girati nel senso opposto, con Black che ride come un indemoniato.
“MAMMAMIA! T’HO VISTO CHE HO FATTO?! DA PAURA!”
Non rispondo, perché se apro bocca lo strozzo. Arriviamo al Mithos col sole che sorge, il cielo che si tinge di rosa. Ma la scritta sulla porta è una pugnalata:
CHIUSO.
Non esiste. Noi non torniamo a casa così. Portiere spalancate, stereo a palla, ci mettiamo a ballare davanti al cancello. Occhi iniettati, facce strafottenti, musica che spacca la quiete domenicale. Le macchine rallentano, ci scrutano. Noi niente, avanti e indietro come alieni su MDMA, finché qualcuno grida: “VOLANTI!”
Spariamo via, al buio, sulla litoranea. Braccio fuori dal finestrino, pelle umida, il beat ancora nel sangue.
“Devo fare piano. Nessun rumore. Entro in casa e nessuno si accorge.”
Abbasso lo stereo duecento metri prima. Scendo piano. Chiudo lo sportello in silenzio. Saluto Black con un cenno muto. Mi avvicino al cancello, mano leggera sulla maniglia.
E suono il citofono.
CAZZO.
La luce del giorno mi ha tradito.
DESTRA O SINISTRA
L’after era stato un massacro psichedelico. Una tempesta lisergica, un delirio collettivo. Il Gatorave. Verde ovunque, cazzo, pareva d’essere finiti dentro ‘na palude aliena, un incubo anfetaminico che non smetteva di pulsare. Trapezisti che piovevano dal soffitto, mezzi sbroccati che pestavano sui bidoni come fossero batterie da stadio, cyborg tossici sputati fuori da un film cyberpunk girato con due lire. E poi Kallina, Brusco… e un lampo bianco, secco, di quelli che ti aprono la testa come un’anguria troppo matura.
Ancora con la cassa di Roby J martellata nei timpani, ci trasciniamo fino alla macchina, ombre sporche su un asfalto sudato. Brusco si incolla al volante, accende lo stereo e si fonde con la carrozzeria. Io manco lo cago, mi lascio cadere accanto a Nando, che sembra già mezzo svenuto, l’anima evaporata sotto il neon marcio del parcheggio. Fuori, Kallina e Brusco fumano come ciminiere impazzite, si sparano dentro roba che farebbe impazzire un cavallo. Due ore di nebbia, fumo denso e occhiate vuote, persi in un’apnea tossica senza fine.
Poi, all’improvviso, Brusco decide che si parte. Ma mica per tornare a Roma. Macché. Ha promesso di portare Kallina a Reggio dalla madre. Solo che c’è un piccolo dettaglio: Nando, accasciato dietro come un cadavere tiepido, ha ancora le sorpresine addosso. E Kallina non ci sta.
“Oh raga, non possiamo andare in giro con ‘sto coglione carico come un mulo. E se ci fermano?”
È un tipo previdente, lui. Uno che pensa al bene comune. Così, senza manco svegliare Nando, gli infila la mano nel giubbotto, arraffa la bustina e… beh, problema risolto nel modo più ovvio.
Si parte. Brusco guida con la precisione di un bradipo strafatto, io e Nando dietro, con Nando che continua a dormire il sonno dei giusti. Kallina accanto, a fare da navigatore.
Col senno di poi, è stata una pessima idea. Perché Kallina, prima di partire, s’è pippato tutto il malloppo di Nando come fosse zucchero filato. Risultato: ogni cazzo di bivio diventa un trip mentale.
“Di qua raga, sicuro. Destra.”
Giriamo a destra.
“…O forse era di là?”
E giù inversioni, deviazioni, bestemmie. Due ore in un limbo di strade uguali, prigionieri della mente impallata di Kallina. Due ore di giri senza senso, mentre l’auto diventa un girone dantesco su quattro ruote. Il destino è segnato: o diventiamo anime erranti su ‘sto asfalto maledetto, o ci riportiamo Kallina a Roma e buonanotte ai suonatori.
Poi, all’improvviso, la svolta. Il miracolo.
“Fermate, fermate! Mi sa che è qua!”
E lo era, Cristo santo.
Ancora oggi ringrazio la mano invisibile che ci ha portati fin lì. Perché, giuro su Dio, se non fosse andata così, saremmo ancora là, a girare a vuoto. O peggio. Molto, molto peggio.
TORO SEDUTO HA BUCATO
Era l’estate del ’95, l’estate in cui il caldo ti schiacciava il petto e la realtà si piegava sotto il peso del sudore e dell’LSD. Era l’estate in cui c’era THE WEST. La riserva. Il richiamo della giungla sintetica echeggiava da giorni nei nostri cervelli fritti, e noi ci preparavamo come dannati a quel battesimo tribale di bassi e delirio. Una settimana di fomentazione, chiamate clandestine, dosi nascoste nelle scarpe e corpi affilati come coltelli per il grande rito.
Noi, branco di sciamani tossici in costume da indiani post-apocalisse. Chi con una piuma rubata a un gabbiano morto sulla spiaggia, chi con un poncho di pelle cucito da una nonna inconsapevole, chi, come me, con un gonnellino di felpa tagliata male, una maglietta fluorescente dell’Olanda e i capelli biondo platino. Guerrieri del caos. Avanguardia della rovina.
Ore quattro del mattino. Siamo pronti. Sembriamo un carnevale psicotico su ruote. La mia diligenza: una Rover 111 nera, quattro metri quadri di disagio meccanico con interni in alcantara rovente, un cesso su quattro ruote con pretese da macchina seria.
A bordo con me: Marc, torso nudo, vernice blu sulle guance e un sorriso da squilibrato; Pecca, la sua fotocopia con più piume e meno sinapsi funzionanti; e Roberta, ribattezzata “Gnocca Seduta”, un mix letale tra Pocahontas e una pornostar da VHS.
Statale Aurelia. Le prime luci dell’alba sfregiano il cielo, la cassetta nell’autoradio gira in loop da ore, il basso pulsa, le ruote mangiano chilometri. La bottiglia d’acqua, arricchita di pastarelle sbriciolate e francobolli psichedelici, passa di mano in mano. Ridiamo. Dio, se ridiamo. Senza motivo, senza senso, solo per sentire il suono della nostra esistenza dissolversi nell’aria calda della notte.
Poi. Bibbona. Il Destino ha voglia di scherzare.
BUCATO. Posteriore destra.
Merda.
Accosto. Corsia d’emergenza. Domenica mattina. Sette e qualcosa. Sole che scava crateri nelle tempie. Scendo dalla macchina, incazzato. Loro? Loro ridono. Bastardi.
“Scendete e datemi una mano, cazzo!” urlo.
Scendono. Continuano a ridere. Pecca si accascia sul guardrail come se fosse un divano imbottito di ketamina. Marc si specchia nel finestrino cercando di capire se la vernice blu gli dona. Gnocca Seduta mastica una Big Babol come se fosse l’ultimo pezzo di cibo rimasto sulla Terra.
Io cerco il crick. Cerco la chiave. Cerco la ruota di scorta. Loro, niente. Statua.
Poi, il rumore di un motore. Le risate muoiono all’istante. Un brivido mi sale lungo la schiena. “Se sono le guardie, siamo fottuti.”
Mi alzo.
Non sono le guardie.
È una Fiat Marea.
Dentro, una famiglia da pubblicità di biscotti. Papà, mamma, nonni e una bambina con gli occhi sgranati incollata al finestrino. Sguardo fisso su di noi, paralizzata dallo spettacolo di quattro schizzati travestiti da indiani che ridono istericamente accanto a una Rover mezza sfasciata.
Per un attimo penso: “Ma che cazzo ci guardano?”
Poi realizzo.
Siamo IL delirio incarnato.
Se io fossi stato al loro posto, avrei premuto forte il piede sull’acceleratore e me ne sarei andato nel più breve tempo possibile. Ma loro no. Restano lì, imbambolati, con la bambina che probabilmente quella notte farà sogni in cui Pocahontas si spara linee su un cofano bollente.
Troppo. È troppo. E ci pieghiamo dalle risate. Quelle risate pure, che sanno di eccesso e disperazione, di trip e di catarsi, di vita che sfugge tra le dita ma che in quel momento non potrebbe essere più perfetta.
E quella risata non ci ha più lasciato. Mai più.
Neanche adesso, mentre lo scrivo.
Perché questo è THE WEST.
Dove tutto è possibile.
“BRUSCO” SANDRO
Brusko Sandro è una leggenda. Di quelle sporche, marce, che tutti conoscono ma che nessuno vuole ammettere di conoscere. Compare dal nulla, occhi pesti, sorriso storto, e ti inchioda con un’altra delle sue storie al confine tra il reale e il trip mal gestito.
Un metro e settantacinque, settantasette chili di disastro su due gambe. Sempre con gli stessi pantaloni di una tuta viola in pail, bruciati qua e là dai tizzoni delle canne, e un bomber rubato in discoteca che da anni ripassa con l’Uniposca per tenere viva la scritta ‘Duplè paura’. In testa, un cappello con la scritta metallizzata ‘King’, che gli copre la calvizie che nega con ferocia. Da dietro, una coda di cavallo lunga fino alla schiena, ultimo baluardo di una gloria andata, reliquia di quando si credeva il re della pista invece che un relitto da after.
Brusko Sandro non lavora e non ha mai lavorato. Eppure, c’era sempre. In ogni festa, ogni club, ogni rave. Un infiltrato perfetto, un ninja dell’imbucata, un maestro dello scrocco. Nessuno lo voleva, ma c’era sempre. Sandro ti agganciava e non ti mollava più. Ti svuotava il cervello con storie che nessuno aveva verificato ma che lui raccontava come se fossero vangelo. Si buttava per terra, mima scene, interpreta ruoli, urla, ride, piange. Un attore tossico senza copione. E tu? Tu restavi lì, intrappolato, sperando che un miracolo lo facesse sparire.
Viveva in un buco vicino Roma, ma aveva infestato mezza Italia. Emilia compresa. Piccole truffe, scambi loschi, spaccio di fuffa. Guidava una Renault viola con la spia della riserva fissa accesa e l’abitacolo sommerso da cassette dal ’90 a oggi, un museo ambulante della techno italiana. Guida con le ginocchia, rolla con una mano, con l’altra smanetta tra le cassette. Ogni traccia ha una storia. Ogni storia è più assurda della precedente.
“Oh, una volta ho visto uno pisciare in pista al Duplè… Un’altra ho trovato una piotta per terra… E quella volta che ho venduto le pillole della nonna per delle paste? Ahahaha!”
Era un’ombra. Una piaga. Un problema per tutti i buttafuori d’Italia. Io l’ho visto entrare all’Exogroove al Momà di Perugia, venti gorilla all’ingresso, cento sacchi per entrare. Lui? Ha puntato una ragazza a caso, le ha urlato “ASPETTA!”, si è infilato nella folla ed è sparito. Ho visto scambiar mezza pasticca finta per mezza vera. Ho visto aspettare la fine della serata per rastrellare paste, fumo, soldi e documenti da rivendere al miglior offerente.
I buttafuori lo conoscevano. Lo odiavano. Lui era il buco nel loro sistema.
Io ci sono uscito un sacco di volte, con Brusko Sandro. Ma lui preferiva girare da solo. Da solo arrivava ovunque. E giuro su Dio, non l’ho mai visto uscire di casa con più di diecimila lire in tasca. Ma tornava sempre con almeno cento. Sempre.
Lui era l’ultimo a lasciare la festa. Fumava con tutti, parlava con tutti, raccontava cazzate fino all’alba. E quando non c’era più nessuno, quando tutto era finito, lui era ancora lì. Sull’ultimo marciapiede, con l’ultima canna, pronto a raccontarti tutto. Lì, nella sua Renault viola, con la cassetta della serata infilata nel mangianastri. Naturalmente, gratis. Naturalmente, strappata al DJ di turno per sfinimento.
E ora vi chiederete: ma ‘Brusko’ è il suo cognome o il suo soprannome?
Beh, Brusco era il cognome di un povero disgraziato che una sera, al The West (Manila), si è trovato depennato dalla lista omaggi. Perché? Perché Sandro, con la sua vista da sciacallo, ha letto il nome Brusco sulla lista, lo ha urlato all’ingresso e si è infilato dentro. Da quella notte, per tutti noi, lui è stato Brusko Sandro. E lo sarà per sempre.
Il motto di chi lo conosce?
Di Brusko Sandro ce n’è uno, ma basta e avanza.
IL POSTO DI BLOCCO SENZA FINE
Non ho la più pallida idea di dove cazzo mi trovo, ma cazzo, so perfettamente da dove vengo, dove sto andando e con chi. Dietro di me ci sono io, il Marcio e un napoletano preso dal marciapiede, uno stronzo dell’autostop che non sa nemmeno che cazzo gli sta succedendo. Alla guida c’è uno dei fratelli “Mo t’acchiappo”, l’altro è al suo fianco, Kallina, sempre con quegli occhi rossi da semaforo rotto. La notte al Deskò ci ha svuotato il cervello e ora siamo diretti al Gatto e la Volpe, l’after del cazzo di Syncopate. Troppa house per i nostri gusti, ma c’è quella cazzo di saletta techno-progressive che fa paura, e la consolle… una roba da metterti a rischio penale per un paio di ore di follia.
Il viaggio? Come sempre, un cocktail di illegalità, stereo a palla, canne che si accendono a raffica come se avessimo appena trovato una scatola di fiammiferi in fiamme. Ma stavolta c’è qualcosa che mi rode dentro la testa, un tarlo che non mi molla. Dovevamo mollare un mezz’etto di roba a un amico di Vada, nascosto nella carrozzeria della Golf, vicino al fanale posteriore destro. Ma, ovviamente, quella merda si è incastrata. Non c’è cazzo di modo di tirarla fuori. E ora? Ce la portiamo in giro per l’Italia come se fosse un ordigno nucleare pronto a saltare.
Ci siamo organizzati. Un sacchettino con due pastarelle a testa, per ogni evenienza. Kallina se le tiene in bella vista sul cruscotto, come se stesse trasportando Fisherman’s Friend. Ma al casello, niente sorprese. Pula è sparito. Tutto fila liscio, come da manuale.
Chiediamo al casellante: “Girate là, viale lungo, poi sul ponte e siete arrivati.” Facile, lineare. Ci sentiamo al sicuro. Ah, beata ignoranza. Usciti sul viale e BAM! Benvenuti al festival della polizia. Volanti dei carabinieri ogni cinque metri, agenti con scatole di guanti in lattice sui tettucci. Dall’altra parte? Camionette pronte a perquisire ogni angolo. Non è un film, è peggio. Sembra Scarface, ma senza villa e senza soldi.
Kallina, che in quel momento sembra il cazzo di Sherlock Holmes della lucidità, capisce subito che la situazione puzza. Fa sparire la roba come se fosse un mago. Tocca al napoletano. Dove metterla? Le mutande. Così, in un batter d’occhio, siamo fermi.
“Documenti. Patente. Scendete.”
Il giorno del giudizio finale. Le forze dell’ordine sono fuori controllo. È un’operazione di recupero post-apocalisse, decine di auto fermate, decine di perquisizioni. La nostra fine è scritta. Ci smontano la Golf, ma niente. Neanche un cenno al portabagagli. Se non siamo degli scemi, non si aspetteranno mai di trovare roba lì. Noi, però, la portiamo incastrata nella carrozzeria. Geniali, eh?
Arriva il momento della perquisizione personale. Uno di noi deve spogliarsi nella camionetta. Kallina, che un minuto fa sembrava l’incarnazione della lucidità, si offre volontario. Peccato che si è dimenticato che ha due pastarelle nelle mutande. Per una botta di culo che non si può spiegare, i caramba lo guardano e si diffidano. “Troppo entusiasta.” Così scelgono il napoletano.
Occhi che si scambiano. Lui ha la roba addosso. È finita, lo sappiamo.
“Noi non lo conosciamo, eh!” mormoriamo all’unisono. “Gli abbiamo dato un passaggio. Non sappiamo nemmeno come si chiama…”
L’attesa è una tortura. Poi il napoletano esce dalla camionetta, sorridente. Disinvolto. È un maestro. Ha infilato la roba nei jeans senza farsi beccare. È libero. Siamo salvi. Il caramba ci fa un cenno. “Potete andare.”
Non ce lo ripetiamo due volte. Cominciamo a camminare verso il Gatto e la Volpe. Ma prima di entrare, altro posto di blocco. “Scendete. Documenti.”
“Ci hanno già perquisiti cento metri fa!”
“Avete il verbale di perquisizione?”
No.
“Allora scendete.”
Cazzo, ecco il trucco. Il verbale, la fottuta chiave per non farsi aprire come tacchini ripieni ogni venti metri. Impariamo la lezione, maledizione.
Il caramba è distratto. Kallina ha una genialata: sterziamo, scivoliamo sulla discesa accanto, e via, filiamo via. Grandioso. Peccato che la strada finisca contro un cancello chiuso di una fabbrica.
Soluzione? Abbandoniamo la Golf, corriamo a piedi, scavalchiamo una collinetta e, in un attimo, siamo dentro il Gatto e la Volpe. Salvi. Finalmente.
Il resto? Il resto è un after da paura. Noferini fa esplodere la saletta progressive, piccola ma letale. La botta è enorme. E questa volta, tutto il necessario è al sicuro.
FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE
- mollò i francobolli dopo quella notte all’Abacab, fuori Terni. Torna a casa, chiude la porta dietro di sé, si barrica in bagno, tutto buio tranne il riflesso sgranato che gli urla in faccia dallo specchio. Si guarda in faccia, cazzo, quella merda gli scorre nelle vene e gli fa schifo, ma non è finita. Prende la roba che gli è avanzata – due strisce, un angolo di carta stagnola – e con una specie di eroica determinazione decide che basta. La scarica nel cesso. Ma, in quel momento, succede. Un applauso scrosciante, ovazioni, cori da stadio, il rumore di un inferno che ti applaude. Si guarda intorno. Solo piastrelle sporche e il suo volto che si riflette, una faccia che non riconosce. Nessuno a parte lui. L’ultima ovazione prima del blackout. E poi il buio. Come una falce che ti taglia il respiro.
- smise dopo quella cazzo di notte bruciata in una discoteca a Rivazzurra. Si svegliò all’alba, nel mezzo di un giardino che non conosceva, vestito, ma con quella sensazione strana, come se qualcosa stesse stringendo la sua pelle, come se non fosse più dentro il suo corpo. Si toglie i jeans e, boom, l’orrore: non sono le sue mutande, ma quelle di un altro. Due taglie più piccole. Strette come un cappio che gli taglia la vita. Ma cosa cazzo è successo stanotte? Non si ricorda un cazzo, solo una nebbiolina che gli gira nel cervello. Si sente soffocare. Ma è troppo tardi, ormai è solo il corpo che va avanti.
- decise che il momento di piantarla era arrivato in autostrada, tornava dall’Insomnia. Obsessivo come sempre, con un’idea che gli si ficca in testa come un chiodo e non se ne va. Deve ascoltare quella cazzo di canzone degli 883. Si attacca al tasto “search” dell’autoradio e, da Firenze Signa a Magliano Sabina, cambia stazione ogni sei secondi. Un’ora di scorrimento, tre ore senza trovare una cazzo di traccia. Il cervello gli esplode. Non la trova. Non trova nemmeno sé stesso. Il buco nel cuore si fa più largo.
E poi c’era F., la sua cazzo di tasca bucata. Partenza da Roma, direzione Jaiss. Nella macchina manca il “carico”. Panico. M., il padrone dell’auto, sbianca, si congela. Parte la perquisizione isterica: mani sotto i sedili, piedi sui tappetini, mani che scavano come se cercassero l’uscita da un labirinto. Poi il raptus: afferra i tappetini e li lancia fuori dal finestrino, come un pazzo, come se potesse cancellare il problema. Fine della ricerca. Ma, una settimana dopo, il cane del padre di M., annusando i resti della macchina, trova un residuo di sostanza sparso sul tappetino, lo ingoia e finisce dritto dal veterinario per una lavanda gastrica. Il padre non ha mai capito cosa diavolo ha ingoiato il cane. E il cane lo sa.
- era il tipo socievole del gruppo. Quello che faceva amicizia ovunque. Al bagno, soprattutto. All’Insomnia si mise a chiacchierare per 45 minuti con un tizio di Bologna tra la Patchwork Place e la Divine Stage. Un’altra volta si incastrò davanti ai televisori, incollato al GP del Giappone con due sconosciuti, uno di Montelupo e l’altro di Sarzana. Venti giri di pista. Al penultimo, se ne andò, li lasciò lì, con la bocca aperta, a fissare un futuro che non esisteva più.
- invece, cazzo, era il farmacista del gruppo. Sapeva i prezzi, le fonti, ogni dettaglio di qualsiasi cosa avesse un principio attivo, e anche quelli che non lo avevano. Una volta, a Miramare, in un appartamento affittato per la solita settimana romagnola, si infilò in cucina e aggiunse due “dadi Star” speciali al sugo dell’amatriciana. Bucatini alla follia. Piatto unico, irripetibile. Stu-pe-fa-cen-te. Cazzo, se era stupefacente.
Si dice sempre che prima o poi si smette. Che si cresce. Ma certe storie, certe notti, non vanno via. Restano lì, appiccicate alla pelle come tatuaggi sbiaditi, sospese tra leggenda e delirio, a ricordarti che un tempo sei stato parte di qualcosa di più grande. Qualcosa che non si racconta. Qualcosa che si vive.
ASH ASH ASHRAM
Era un cazzo di mercoledì tranquillo di aprile del ’95. Il sole che sfonda le persiane, una luce che entra e brucia tutto. Ho appena scartato il pacco di vinili arrivato da Firenze. L’apro con la frenesia di un tossico che apre la busta della roba, la voglia di entrare dentro, di farlo subito. C’erano dentro delle bombe, roba da guerra, roba che ti fa volare senza chiedere il permesso. Ma poi l’occhio ancora lucido mi cade su un flyer microscopico. Piccolo, strano, assurdo, come quelli che trovi in fondo alle tasche dopo tre giorni di festa, tutto sgualcito, pieno di segni di vita vissuta. UNIVERSO BETA presenta: INAUGURAZIONE ASHRAM. Mezzanotte – Mezzogiorno. UBJ, Masterfunk, Roby J, Miki, Sandro Vibot, Ciro, Gabri Fasano. Minchia. E dove cazzo sarebbe ‘sto posto? Fucecchio? Mai sentito. Un buco sperduto fuori dal triangolo del bene e del male: Ponsacco, Tirrenia, Empoli. Mah. Lo ficco in tasca, non ci penso troppo e me ne vado.
Due giorni dopo, il solito gruppo lisergico si raduna al bar. Discussione seria: dove cazzo passare il sabato? Dove festeggiare il compleanno del C.? E, cosa ancora più importante, che cazzo di spesa fare per il nostro picnic del weekend? Una sola idea rimbalzava tra le nostre teste distrutte. Che cazzo ti dico a fare? I M P E R I A L E. Non fa male, sale sale. Ma i sogni si schiantano contro un muro di cemento armato chiamato “sghei”. “Oh raga, qui non ci stanno i soldi per l’after!”. Silenzio. Ci guardiamo, e il bivio si fa grande come una cassa del Jaiss. O solo imperiale, o questa roba strana lì. Estraggo il flyer, piccolo ma presente. La crew mi guarda come se fossi pazzo: “Fucecchio?!”. Nessuno lo conosce, nessuno ci è mai stato. Ma la voce di Ambrogio Fogar, il nostro nume tutelare delle trasferte, sussurra che vale la pena rischiare. Mille chilometri tra andata e ritorno. Che sarà mai?
Il giorno dopo, ore 16:00, siamo stipati nella mia Fiat Uno grigiolina. “Bruno” lo chiamavo. Un catorcio, cazzo, ma fedele. Sessanta all’ora, massimo. Ma ci siamo. Partiamo. Viaggio lento, cervelli in progressione alterata, tra solfumigi, vodka calda e cassettine di Miki. La Uno diventa un privè ambulante. Quattro ore di ondeggiare e, finalmente, siamo al casello. Abbasso il finestrino a manovella e chiedo al casellante: “Scusi, Fucecchio?”. “Adiritto”. Ok, adiritto dev’essere dritto. Ripartiamo. Poco dopo, manco fossimo Benigni e Troisi, siamo lì. Campi a destra, campi a sinistra, e un’insegna lampeggiante: “Trattoria del Camionista”. Perfetto. Tre ore alla mezzanotte, quale posto migliore per passare il tempo? Entro, chiedo un succo di frutta (l’unica cosa che posso ingurgitare senza rischiare di vomitare un polmone) e mi attacco al biliardo. Stecca in mano, siga in bocca, adrenalina in corpo.
Verso le 23:30, si riparte. “Disco”… beh, chiamamola capannone. La fila c’è, ma noi sembriamo alieni. Ci guardano strano. “Ma questi da Roma che cazzo vogliono?”. Lo capiamo subito: non è il solito pubblico, questi sembrano contadini in cerca di un’illuminazione mistica. Qualcosa non quadra. Ma siamo qui, entriamo.
Che cazzo è ‘sto posto? Musica c’è, gente pure, ma l’atmosfera è strana. Gira, gira, e alle quattro siamo già fuori con l’aria scazzata di chi ha capito tutto. Mai mollare la botta vecchia per quella nuova. Sai quello che lasci, non sai quello che trovi. Ci cambiamo, torniamo alla Trattoria del Camionista. La signora dietro il bancone ci guarda come se fossimo zombie appena usciti da un’apocalisse chimica. Ci buttiamo su un tavolo, ci reidratiamo. Masticare è fuori discussione. Sigaretta dopo sigaretta, discorsi incomprensibili anche per uno schizofrenico. Poi basta uno sguardo. Si va all’after. Con un patto: se fra un’ora è ancora moscio, torniamo a casa.
Camminiamo. I contadini del posto, freschi di alba, ci guardano spaesati. Il solito dilemma domenicale: “Ma questi si sono appena svegliati o non hanno mai dormito?”. Poi l’angolo. E la visione. Gente ovunque. Drag queen, pattinatori, creste fluo, outfit spaziali. Ci guardiamo e ridiamo. “Qui ce ne andiamo tra due giorni.”
Saltiamo la fila grazie al timbro. Dentro è il caos perfetto. Un vortice di empatia che solo certi posti possono generare. Un effetto domino di sorrisi, sguardi, connessioni invisibili. “Benvenuti nel Paese delle Meraviglie. Lei ormai è di casa”. Roby J in consolle, ipnotico. Un’onda sonora che ti smaterializza e ti ricompone. Ci perdiamo. Ognuno col suo viaggio. La musica riempie i polmoni, l’anima, il tutto. Sorrido. E mi lascio andare.
Ore dopo, boccheggiando, arrivo in bagno. Un grido improvviso mi risveglia dal delirio: “Mamme tranquille, i vostri figli sono al Fuori Orario!”. Bettina. La mia vocalist preferita. Scoppio a ridere. Penso a mia madre: se mi vedesse ora chiamerebbe direttamente la neuro. Ma chi se ne frega. L’unica cosa che conta è esserci. Far parte del rito, di un movimento che diventerà leggenda.
Mi ributto nella folla. E sparisco.
THE WEST QUEL CHE SI VEDE È
Sabato sera. Il sabato che aspetti per una settimana intera, ma stavolta c’è qualcosa nell’aria che puzza di leggenda. 9 settembre 1994. Una data che ti brucia in testa. Partenza da Anzio alle 21.00, destinazione Club Imperiale. Dodici cazzo di ore di delirio, per salutare l’estate come si deve. Un “mezzanotte-mezzogiorno” che ti spaccherà il cervello. Tognetti, Farfa, Miki, De Tiberiis al privé, e Paul Cooper da UK. Una line-up che ti fa venire voglia di strapparti la pelle per l’eccitazione.
Dentro la Clio, l’aria è una bomba di benzina e aspettativa. La cassetta di Farfa martella la testa come una coltellata, ritmo sincopato che segna i nostri cazzo di 427 chilometri settimanali verso la terra promessa, la terra di nessuno, quella dove i corpi diventano uno, dove l’estasi è collettiva, la roba è potente, il respiro è l’unica cosa che ti tiene vivo. Arriviamo all’una, e il tipo della lista scuote la testa. “Ragazzi, oggi non entrate. È pieno come un uovo.”
Che cazzo? Otto ore di viaggio per nulla? No, non può finire così. Ci buttiamo di nuovo in macchina, furiosi, bestemmie che volano in ogni direzione. Musica accesa. Non ci stiamo a fermare. Attacchiamo bottone con un gruppo di ragazzi di Aulla. Stessa merda, stessa frustrazione. Però loro hanno un nome: Raulo. Un after segreto a Vada, alla Baita. Solo per pochi, solo per quelli che sanno.
Ci guardiamo, ed è un attimo. Si parte. Seguiamo la Golf targata Genova come un branco di lupi. La processione notturna si allunga, un serpente di macchine che si perde nelle campagne toscane, anime disperate in cerca di quella cosa che ti fa battere il cuore e ti fa dimenticare tutto. È il caos, è la speranza. Ore quattro del mattino. Solo i vampiri sono in giro, ma non ce ne frega un cazzo. Poi, d’improvviso, eccola. La Baita. Finalmente.
Entriamo. L’atmosfera ti entra dentro, ti gela la pelle, ti scuote i nervi. Sound system che ti esplode dentro come un tuono, una consolle che sembra un cazzo di altare sacro. E sopra la consolle, un cartello gigante: Miki, Farfa, Open Space, Charlie Hall, Paul Cooper, Roby J. Il meglio del sound del Tirreno, pronto a incendiare la notte, a mandarti a puttane tutto il resto. E la gente… Dio santo, la gente. Un caleidoscopio che ti travolge. Vite che si intrecciano in un trip mistico, lisergico, al limite del razionale. Occhi sgranati, sorrisi congelati, corpi che si fondono e si lasciano andare al ritmo del cazzo di universo.
Paul Cooper è lì. Sta suonando con un Roland DJ-70. Mentre mixa, solleva una cornetta del telefono, ci parla dentro e la sua voce ci arriva distorta, robotica, metallica, fluttuando sopra un groove alieno che ti fa sentire fuori di te. È suono che viene dallo spazio. E noi siamo lì, sospesi nel tempo, parte di qualcosa che non si fermerà mai, qualcosa che rimarrà incastrato nel cuore, un momento che non morirà mai.
I movimenti passano, le mode vanno a farsi fottere. Ma certe notti, certe esperienze non te le scordi mai. Resta tutto tatuato nel cuore, inciso nella carne. Perché non sono solo notti, sono visioni, rivelazioni. E quel cazzo di cartello sulla consolle, l’ultimo dettaglio prima dell’alba: “THE WEST AFTER HOUR… quel che si vede è!”
GOD SAVE THE DJ RESIDENT
Ore 22:00, sabato sera. Appena finito di mangiare, il cazzo di telefono squilla come un dannato. Ogni volta che rispondo c’è qualcuno che vuole sapere della serata. A che ora suona la star? È già arrivata? Mi metti in lista? Ma che cazzo, che mi stai chiedendo? Io ho un mal di testa che mi esplode e vorrei solo mandare tutti affanculo, sparire.
Troppa roba da fare stasera. Lista piena, se tutto va bene stasera mi porto a casa i soldi per la nuova scheda audio. E poi c’è l’inglese. Cristo santo, l’inglese. Dovrò tirar fuori il mio accento da porno anni ’90 per scambiare due parole con l’ospite e passargli le tracce. Se gli piacciono, magari finisco sulla sua etichetta. Una traccia giusta, e sei dalla parte giusta, dietro quei cazzo di giradischi.
Laptop pronto, tracce selezionate, cuffie in testa. Bevo un goccio, giusto per sciogliere la tensione, per ammorbidire i nervi che già mi punzecchiano. La gente comincia a entrare. Saluti veloci, mani sudate che si intrecciano alle mie, bocche che parlano ma non sento un cazzo. Ho le cuffie in testa, non capite? Faccio finta di ascoltare, sorrido e intanto butto dentro la prossima traccia.
Eccola. Nuova di pacca, spaziale, beat spezzato, una bomba. Ma non piace. La pista è ferma. I cazzi di questi, fermi, a bere e chiacchierare. Stronzo io o stronzi loro? Non gira, non scatta. Forse ho sbagliato setup, forse è solo una di quelle serate che non riesci a salvare. PR che blatera, che cazzo me ne frega. Non mi interessa.
Vorrei essere ovunque tranne che qui, ma non posso permettermelo. Non posso lasciare che qualcuno mi soffi il posto, che mi faccia fuori. Cambio traccia, ne metto un’altra, un’altra ancora. Niente. I mix vengono fuori di merda. La tensione è un nodo che mi sale nella gola. Poi, finalmente, arriva quel break: tappeto, cassa morbida, synth che ti entra dentro, ti ruba l’anima. Un urlo dalla pista. Ecco, finalmente, cazzo.
Sento il brivido. Ho trovato il binario. Un’altra traccia. Mix perfetto. Il mixer è mio, il club è mio. Ora sono io a decidere. Prendo l’energia, la plasmo, la restituisco, e la pista mi risponde. Questa è la droga, cazzo. Questo è il motivo per cui fai il DJ. Per questa cazzo di connessione che ti fa sentire tutto.
Non posso esagerare. La star deve avere il suo momento. Ma adesso, cazzo, tocca a me. Metto un mio pezzo. Lo equalizzo bene, nessuno noterà la differenza. Sicuramente è colpa della scheda audio di merda.
E arriva lui. Si mette lì, davanti. Mi chiede che cazzo sia quella traccia. Gli dico che è mia. Annuisce, un cazzo di complimento. Boom. Secondo brivido della serata. Questo è quello che ti fa andare avanti, non le serate, non la musica, ma l’attenzione di chi è sopra di te, che ti guarda, che ti sente. È quella roba che ti tiene acceso, che ti fa andare avanti.
Fine serata. Busta paga. Mancano soldi. “Recuperiamo la prossima volta.” Ma vai a farti fottere, quante volte l’ho sentito? Quante volte lo sentiremo ancora? In questo cazzo di mondo la passione e il business non si incontrano mai. Ti fregano, ti usano, ti svuotano. Ma la fiamma non si spegne. Si affievolisce, si trasforma, ma non si spegne mai. E chi ti ha fregato oggi, domani sarà già dimenticato.
Ore 6:30, domenica mattina. Torno a casa. Incazzato per i soldi, ma con il cuore leggero. Ho fatto quello che amo. Ho fatto divertire. Ho spaccato. Chissà se domani ci sarà una cazzo di mail da quel DJ. Chissà.
SOTTO ZERO? NO, POINT ZERO.
Era il 5 gennaio del ’95, la vigilia della Befana. Ero lì, buttato nel letto come un cadavere, distrutto, reduce da trentasei ore di coma autoindotto. Capodanno al Cocoricò, after al Cellophane, primo dell’anno al Pachá. La mia trilogia della devastazione, cazzo.
Quando finalmente riapro gli occhi, è mezzogiorno passato, e il mio stomaco è sigillato, chiuso a doppia mandata. L’anfetamina mi gira ancora nelle vene, mi strizza l’intestino e mi fa venire voglia di scolare solo acqua frizzante e bestemmie. Barcollo fino alla cucina, infilando qualcosa in bocca senza nemmeno sapere cosa sia. E poi il telefono squilla, cazzo. Quasi mi cago sotto. Rispondo.
Massimo, esaltato come un cane rabbioso:
— Fratè, stasera si va al Torquemada!
Non ci penso, il mio cervello fa già “sì” prima che possa aprire bocca.
— Tienimi un posto!
Il Torquemada era *LA SERATA*. Firenze, Happyland, Campi Bisenzio. Un buco di club, ma con un’anima che faceva tremare tutto, cazzo. Toscana batteva Riccione uno a zero, senza discussioni. Se volevi sentire i migliori, quelli che ti staccano il cervello con un beat, li trovavi lì. Non serviva altro.
Mi ributto sul letto, sperando di dormire un altro po’, ma l’adrenalina mi picchia in faccia, mi schiaffeggia. Mi vesto come un soldato: divisa da guerra, jeans strappati, Doctor Martens slacciati. Pronto.
Alle otto e mezza, la Polo di Massimo mi raccoglie sotto casa. La macchina è piena, tipo *banda del buco*: Massimo al volante, Fabrizio come navigatore, dietro io, Umberto e Fernando. Sorrisi storti, guance di plastica per l’effetto Capodanno che ancora gira nei nostri corpi distrutti.
Il viaggio verso Firenze è un incubo: tra un documentario sulla fauna tossica e un film di sopravvivenza in Siberia. Neve, ghiaccio, micce bruciate per ingannare il freddo. Ci fermiamo all’autogrill, un incontro ravvicinato con i caramba. Ci conoscono, sappiamo chi sono. Ci sniffiamo l’aria. Documenti, controllo di routine, poi il saluto veloce:
— Ok, fate buon viaggio.
Ripartiamo. Una nube di fiato ghiacciato ci avvolge nell’abitacolo. L’Happyland è un alveare impazzito. Parcheggio pieno, lasciamo la Polo in una vietta, sperando che al ritorno sia ancora lì, intatta.
Dentro è il paradiso. Consolle: Ricky Leroy resident, ospite Miki. Animazione Guta. Il tema della serata: “Point Zero”, un traccione che sembra avanti di dieci anni. Quando parte il pausone cantato, il tempo si ferma, il mondo si scioglie. Brividi, occhi chiusi, mani al cielo. Ci siamo dentro fino al cazzo di midollo.
Alle quattro e mezza, la grande famiglia si scioglie. Saluti veloci, pacche sulle spalle, promesse per il prossimo weekend. Braccia conserte, Doctor Martens slacciati, temperatura che non frega a nessuno. Usciamo cantando “Point Zero” come fosse un inno sacro.
E poi… il drama.
Il finestrino del passeggero fracassato. Frammenti di vetro sul sedile, il gelo ci fischia nelle orecchie. Restiamo lì, fermi, a fissare l’auto come se fosse una cazzo di magia che potrebbe aggiustarsi da sola.
Soluzioni:
- Restare fino al mattino, cercare aiuto. Ma è il giorno della Befana e siamo con sessantamila lire in cinque, sigarette contate, e il casello da pagare.
- Ripartire subito, quattrocento chilometri sotto un vento artico che ci strappa la faccia.
Una scelta razionale ci sarebbe. Ma razionalità è roba da stupidi, non per chi si fa otto ore di viaggio per ballare quattro.
Saliamo in macchina. Massimo guida, Umberto davanti, io, Fernando e Fabrizio dietro. Giubbotti tirati fin sopra il naso, cappelli schiacciati sulla testa, io senza guanti. Massimo apre il cofano, tira fuori una coperta di lana. Ce la buttiamo addosso come quattro nonni che si riparano dal freddo.
Temperatura: meno due gradi.
Il vento ci trapassa i denti, la faccia è insensibile, le lacrime che si ghiacciano non appena toccano la pelle. Tra un tremito e l’altro, sfottiamo:
— C’ho un pinguino che me sta a fa’ un blowjob!
Proviamo a fumare, ma l’aria ci spegne tutto sul nascere. Dopo settanta chilometri, ci fermiamo all’autogrill. Un caffè bollente che non serve a un cazzo. Il benzinaio ci ignora. Ripartiamo. Cambiamo posti per non congelare sullo stesso lato. Più che un viaggio, sembra una punizione divina.
Finalmente, entriamo nel Lazio. Un altro benzinaio, un’altra speranza. Stavolta ci va bene. Un tipo con l’anima buona si avvicina, ci guarda storto:
— Ma che cazzo avete combinato?
— Duecento chilometri senza finestrino.
— Voi siete pazzi.
Lo imploriamo. Il Messia si arma di nylon, nastro adesivo e cartone. Ci fa un finestrino di fortuna. Poi ci vede fumare e chiede un tiro. Gli diamo tutto quello che abbiamo. Lo veneriamo come un dio pagano.
Si riparte, finalmente un po’ meno ibernati. Quando arrivo a casa, termosifoni a tutto, mi butto sul letto, ancora vestito. Mi sveglio con trentanove di febbre e il cervello che sbatte dentro la testa.
Ma nella testa, sempre e solo quella traccia.
“Point Zero”.
E, cazzo, nonostante tutto, al Torquemada ci eravamo andati.
IL SIGNORE IN AFTER HOUR
La notte che non finiva mai. The West, il tempio di ogni stronzo che cerca risposte tra fumo e bassi, il posto dove la musica non è più un suono ma una religione. La pista è una distesa di corpi, fusi insieme in una puttana di tribù che non sa più se balla o prega. La gente è ovunque, sudata, isterica, una marea che ti inghiotte come una cazzo di onda. Eppure, tra tutta questa frenesia, c’è lui. L’estraneo. L’intruso.
Lui. Un tipo sulla trentina, vestito come se fosse appena uscito da una riunione di Wall Street. Completino nero, camicia bianca, cravatta celeste che sembra troppo elegante per non nascondere qualche segreto. Si muove tra di noi come se fosse fuori posto, e lo è. Non è uno di noi, non lo sarà mai. Non è nemmeno un uomo, cazzo. È un alieno. Uno yuppie.
“Ma che cazzo fa questo qui?”, mi chiedo, gli occhi stretti, la testa che fuma di curiosità. C’è qualcosa di strano, di scomodo. Ogni volta che il suo corpo attraversa la pista, la gente si sposta come se fosse il Messia, o forse il diavolo. Le teste si girano, gli sguardi si incrociano, confusi, incerti. “Chi cazzo è?” “Un infiltrato. È una guardia!” La voce si fa più forte, ma è un’illusione. Non può essere una guardia. È troppo evidente. Troppo sbagliato. È come se un ravers fosse stato sparato in mezzo a una festa di Laura Biagiotti. Completamente fuori posto. Ma, strano, cazzo, c’è qualcosa che mi attira. Qualcosa che mi fa guardare ancora.
E il mito cresce, come sempre succede quando qualcosa non dovrebbe essere lì. C’è chi dice di averlo visto, chi racconta che qualcuno l’ha sentito parlare. E poi ci sono quelli che lo cercano, per fare due risate, per capire se è davvero così strano.
Nel frattempo, Gabry il caccia pompa la musica. Boom boom boom. La gente impazzisce, ma c’è solo una cosa che conta: lui. Lo yuppie. La creatura che cammina controcorrente, come se fosse in un film sbagliato, come se fosse stato lanciato direttamente in un incubo e noi eravamo troppo occupati a ballare per capire che la sua presenza era tutto quello che ci importava.
Tre ore dopo.
La pista è una palla di corpi impazziti, un masso di carne che rimbalza e si contorce al ritmo della musica. E poi lo vedo, lo sento. Un gruppo di teste intorno a qualcosa, come se stessero cercando di decifrare un enigma. Mi faccio largo, voglio vedere anche io. Cosa sta succedendo?
Lì, al centro, c’è lui. Quello che non apparteneva a nessuno. Un uomo sulla trentina, ma adesso è diverso. Ha i pantaloni grigi che oscillano, il petto nudo, la camicia bianca legata in vita, cravatta in testa come un bandito. Si muove come un animale, il corpo che sfida la gravità, volando, ballando, fluttuando sulle onde chimiche che ci stritolano tutti. La giacca che gira nell’aria come se fosse un cazzo di Tony Manero.
È lui. Ma adesso, cazzo, non è più lui. Ora è uno di noi.
E qualcosa mi dice che lo sarà per sempre.