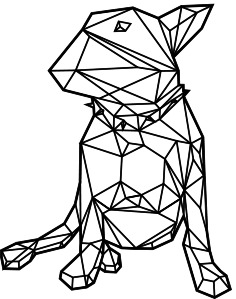Brusco Sandro
Era una figura mitologica, un’icona del peggio, una leggenda vivente delle notti romane. “Brusco” Sandro non era solo un nome, era un marchio di fabbrica, un sigillo di garanzia per ogni storia assurda, ogni serata fuori controllo, ogni impresa ai limiti della legalità. Alto un metro e settantacinque, settantasette chili di pura sfrontatezza, sfoggiava un look che era una dichiarazione di guerra al buon gusto: tuta viola in pail, bucata qua e là dai tizzoni delle canne, un bomber del Duplè rubato anni prima in discoteca e costantemente ritoccato con uniposca bianco per non far sparire la scritta “Duplè Paura”. E poi c’era il cappello, il famigerato cappello con la scritta metallizzata “King”, un cimelio intoccabile che nessuno osava alzare per paura di incorrere in una brusca reazione. Dal retro del cappello scivolava una coda di cavallo lunghissima, una reliquia del passato che toccava il centro della schiena, sfidando impavida le mode e il tempo.
Brusco Sandro non aveva mai lavorato un giorno in vita sua, ma aveva presenziato a tutte le feste più memorabili della capitale e dintorni, senza mai sganciare una lira per ingresso, consumazione o pastarella. Conosceva tutti, ma tutti facevano finta di non conoscerlo. Perché Brusco Sandro aveva il superpotere della logorrea: ti attaccava la pippa e, senza accorgertene, ti ritrovavi spettatore di un monologo epico sulle sue imprese leggendarie. Ogni racconto era accompagnato da gestualità teatrali, urla improvvise per riprodurre le parole della pula quando lo aveva fermato, ruzzoloni per terra per dimostrare come si era nascosto dietro un divano per sfuggire ai buttafuori. Il tutto, ovviamente, senza il minimo riguardo per gli sguardi perplessi degli astanti.
Viveva nei dintorni di Roma, ma aveva lasciato il segno anche a Parma, dove aveva “lavorato” – ovvero spacciato – per un periodo. Il suo bolide era una Twingo viola, sempre con la spia della riserva accesa, trasformata in un museo ambulante di cassette: duecento nastri dal ’90 in poi, un archivio musicale di tutti i DJ più famosi, rigorosamente ascoltati avanti e indietro mentre guidava con le ginocchia, rollava una canna con una mano e ti raccontava per filo e per segno la storia di ogni traccia, con tanto di aneddoti che sfioravano il paranormale.
Lo avevo visto con i miei occhi infilarsi all’Exogroove del Momà di Perugia, dribblando venti buttafuori con una finta degna di Maradona: un urlo “Aspetta!” rivolto a una ragazza a caso, uno scatto felino, e in un attimo era sparito tra la folla. L’avevo visto infilare mezza pillola finta in bocca a qualcuno per riceverne mezza vera in cambio. L’avevo visto uscire per ultimo da ogni discoteca, attendere che si accendessero le luci per rovistare tra il caos abbandonato della notte, raccogliendo tesori: paste, fumo, soldi, documenti da riciclare per qualche colpo di genio.
I buttafuori lo conoscevano bene, Brusco Sandro, perché a fine serata gli svuotava le tasche senza che se ne accorgessero. Ma il bello era che non lo faceva solo per svoltare la serata: lui si nutriva di quel mondo, si muoveva tra i resti della notte come un predatore dell’underground, un archeologo della techno. Partiva sempre da solo e, senza una lira in tasca, tornava con più di cento mila lire, cassette nuove e mille storie da raccontare.
La sua carriera di imbucato raggiunse l’apice al The West (ex Manila), quando lesse al contrario sulla lista omaggio il cognome di un certo Brusco e lo fece suo, presentandosi con nonchalance all’ingresso: “Brusco Sandro, sono in lista”. E così, per tutti, diventò Brusco Sandro per sempre.
Il motto di chi lo conosceva era sempre lo stesso: “Di Brusco Sandro ce n’è uno, ma basta e avanza”. E come dargli torto?